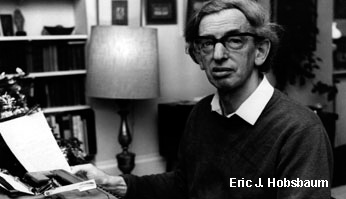Il secolo di Hobsbawm
di Franco Bergoglio
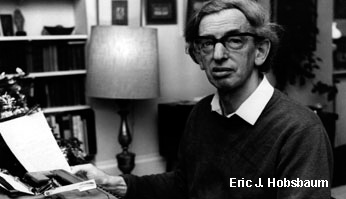
Eric J. Hobsbawm (1917-2012) rappresenta nell’immaginario collettivo la figura dello storico. Definendo il Novecento secolo breve ne ha determinato durata e nome. Per chi si occupa di jazz, poi, Hobsbawm non può che configurarsi come un mito. Questi, nel lontano 1959, scriveva "The Jazz Scene" tradotto da noi come "Storia sociale del jazz" (Editori Riuniti, 1982). Oggi quel libro va annoverato tra le tappe fondamentali per la musica afroamericana. L’edizione francese - ricorda Hobsbawm - uscì per una collana curata dall’eminente storico Fernand Braudel, successivamente tradotta in decine di lingue. Se oggi s’insegna jazz nelle università lo dobbiamo a intellettuali illuminati come Hobsbawm che hanno speso il proprio prestigio su un terreno che allora ai più non pareva decoroso per uno studioso. «Il suo posto nella professione accademica era un po’ come quello dell’omosessualità: un’inclinazione privata di alcuni docenti che non rientrava però nella loro attività accademica», ironizza Hobsbawm.
Nell'autobiografia "Anni interessanti" (Rizzoli, 2004). Hobsbawm ha raggiunto una fama mondiale che - caso raro per uno storico - ha bucato i media; sue interviste sono comparse regolarmente sui quotidiani e sulle televisioni. Sempre in "Anni interessanti" spiega: «Il modo più rapido di identificare una personalità nel nostro mondo saturato dai media è evocarne una o due caratteristiche peculiari: la mia è che sono un professore a cui piace il jazz e che è rimasto nel partito comunista più a lungo di molti altri».
Appassionato di jazz fin dall’adolescenza, testimone commosso del primo tour di Duke Ellington in Europa nel 1933 («la più grande di tutte le band, di cui potrei ancora citare a memoria la formazione»), lavorò successivamente come critico jazz per importanti giornali inglesi a nome Francis Newton, pseudonimo mutuato da uno dei pochi jazzisti neri americani apertamente comunisti degli anni Trenta. Un buon trombettista che incise con Billie Holiday la celebre versione di "Strange Fruit" pubblicata dall’etichetta Commodore. Con questo eroico nom de plume, Hobsbawm, parallelamente all’attività dello studioso, entrò nell’arena della critica.
In seguito spiegò come si fosse offerto al New Statesman per la pagina del jazz principalmente per arrotondare le magre entrate di giovane accademico non ancora in carriera, facendo notare che il rivale Observer ospitava un proprio critico. Era la metà degli anni Cinquanta. Da allora ha scritto di jazz nel suo notissimo "Il secolo breve, 1914-1991" (Rcs Libri, 1997) e in "Gente non comune" (Rcs Libri, 2000) che indaga alcune delle personalita' più singolari del Novecento. Indovinate chi fa capolino tra i luddisti che distruggevano le prime atroci macchine industriali, i guerriglieri vietnamiti, i rivoluzionari di professione e i calzolai radicali inglesi? Hobsbawm inserisce tra le figure chiave del secolo scorso Sidney Bechet, il Caruso del jazz, Count Basie, Duke Ellington e Billie Holiday.
Vicino ai movimenti operai e a quelli di emancipazione femminile fanno capolino le big band dell’era Roosevelt, studi sulla ricezione europea del jazz e analisi dell’archetipo del fan.
Sempre In "Anni interessanti" scrive di questo gruppo: «Allora (…) la passione per il jazz caratterizzava un gruppo ristretto e isolato anche tra coloro che avevano gusti culturali minoritari. Per due terzi della mia vita questa passione unì la minoranza che la coltivava in una sorta di massoneria internazionale semiclandestina, disposta ad accogliere chiunque si fosse presentato con il corretto segnale in codice.
Il jazz sarebbe diventato la chiave per accedere a quasi tutto quello che so della realtà degli Stati Uniti e, in misura minore, della Cecoslovacchia, dell’Italia, del Giappone, dell’Austria postbellica...».
Ecco emergere «dall’interno» il ruolo chiave del pubblico jazz: un uditorio enormemente serio, costituito di fini conoscitori che Hobsbawm per primo ha indagato sul campo, con l’occhio di un sociologo. Lo sguardo dell’esperto e la passione del didatta: poiché, come scrive nell’autobiografia, in piena Seconda Guerra Mondiale, mentre si trovava sotto le armi con l’esercito britannico, Hobsbawm conduceva lezioni di ascolto guidato per neofiti del jazz e ha mantenuto fino a non molti anni fa contatti diretti con il mondo musicale afroamericano: ormai affermato a livello mondiale, nei suoi periodi di insegnamento a New York viveva nel Village e il suo ufficio era ubicato proprio sopra un jazz club. Ancora nel 1987, con l’ articolo «The Jazz Comes back» scritto per la New York Review Of Books, Hobsbawm incideva nel dibattito in maniera autorevole; recensendo in questo caso i libri di critici e musicisti quali Whitney Balliett, Danny Barker, Francis Davis, la storia dello swing sotto il nazismo raccontata da Mike Zwerin e il film "Round Midnight" di Bertrand Tavernier. E faceva il vecchio mestiere di critico con opinioni forti che potevano suscitare le ire degli specialisti.
Nell’articolo in questione, paragonando Europa e USA, esponeva un giudizio sulla ricezione del jazz: «Almeno a partire dal 1930 aveva attratto un considerevole numero di intellettuali, dai vasti interessi culturali. Tuttavia l’alta cultura statunitense fu straordinariamente lenta nel prendere nota di quello che probabilmente resta il più serio contributo americano alle arti del ventesimo secolo».
Questa frase fece infuriare il critico americano James Lincoln Collier, che presa carta e penna, scrisse al direttore della rivista: «Gli intellettuali europei hanno sempre coltivato amorevolmente la propria ignoranza verso gli Stati Uniti e quindi non desta sorpresa vedere uno di loro che nuovamente propone il vecchio ritornello senza senso secondo il quale avrebbero scoperto il jazz prima degli americani, meno sensibili e intellettualmente poco sofisticati. Tuttavia è snervante che questa pretesa arrivi da uno storico sicuramente abituato a investigare bene un tema prima di offrirne delle spiegazioni».
Dopo questa caduta di stile, Collier rincara la dose spiegando come gli europei abbiano ascoltato il jazz non solamente dopo gli americani, ma anche grazie alla loro mediazione culturale.
La replica di Hobsbawm sulle pagine della rivista rappresenta un capolavoro di perizia storiografica, di aplomb britannico nello scartare i trabocchetti sciovinistici e humor: «Collier ha prodotto la migliore storia del jazz che io conosca. Non penso di aver scritto nulla più delle sue opinioni, quando afferma che “gli europei sono stati generalmente più ricettivi degli americani per quanto riguarda il jazz e ne hanno parlato prima e spesso lo hanno anche fatto meglio" (segue citazione puntuale del libro di Collier da cui Hobsbawm ha tratto l’affermazione) e poi una piccola, ma decisa, lezione di storia: «Non ho mai insinuato che gli americani si disinteressassero al jazz o fossero pregiudizialmente ostili ma il fatto che quell’idioma appartenesse così tanto alla loro vita quotidiana gli rendeva difficile trattarlo come forma d’arte e non corrispondeva alle idee che essi avevano su cosa costituisse l’alta cultura in quegli anni. Che il jazz rientrasse in quel gruppo di idee non l’ho mai sentito. Questo non significa che la stampa americana non ne scrivesse e recensisse. C’era molto più jazz a New York che in Europa; e ancora in parte è così.
E persone che ho ammirato molto, come il mio amico John Hammond, sono state in una posizione di gran lunga migliore per commentare il jazz di quella di chiunque altro in Europa, possedendo notizie di prima mano». La querelle tra lo storico gentiluomo inglese e il furibondo critico americano sottende uno scontro di civiltà o, se vogliamo, di opposti imperialismi culturali in cerca di predominio.
Ecco perché la lezione di Hobsbawm - che nello scambio di battute con Collier non accetta la dicotomia USA/Europa ma sposta a un livello alto la riflessione - costituisce un esempio per chi vuole studiare la storia del jazz. |